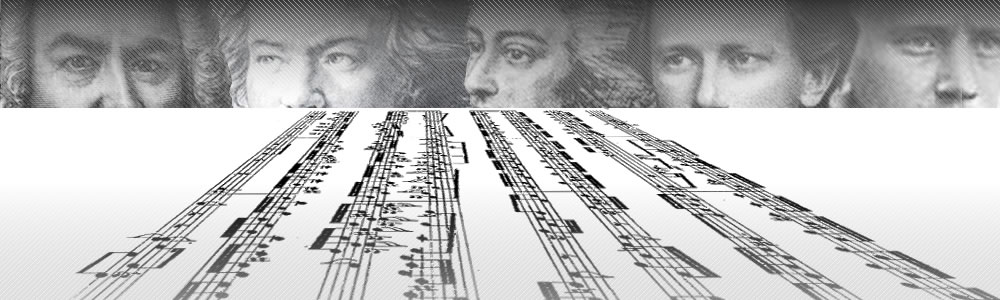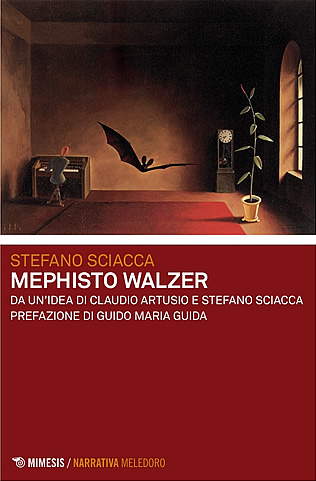 Mephisto Walzer, edito da Mimesis, è l’ultimo romanzo di Stefano Sciacca, un giallo o meglio un noir che mette in scena una serie di elementi di sicuro fascino: una passione amorosa (che forse di amoroso ha ben poco), un caso di omicidio da risolvere e un compositore che cerca di dare suono nientepopodimenoché a Mefistofele.
Mephisto Walzer, edito da Mimesis, è l’ultimo romanzo di Stefano Sciacca, un giallo o meglio un noir che mette in scena una serie di elementi di sicuro fascino: una passione amorosa (che forse di amoroso ha ben poco), un caso di omicidio da risolvere e un compositore che cerca di dare suono nientepopodimenoché a Mefistofele.
Attraverso la lettura ci ritroviamo coinvolti in questa sottile ricerca di Mefistofele, salvo poi iniziare a sospettare che, proprio mentre lo cerchiamo, lui ci abbia già trovati.
L’autore Stefano Sciacca ha risposto approfonditamente e con grande sensibilità alle domande che mi sono sorte dopo la lettura del libro dando vita a una breve ma intensa intervista.
Iniziamo subito con una domanda che riguarda la musica, perché leggendo Mephisto Walzer emerge una cultura musicale molto profonda unita ad una passione intensa: qual è il suo rapporto con la musica? Suona qualche strumento? Soffre di quella che io chiamo “la sindrome di Stoccolma del musicista?”
Sono contento che dal romanzo emerga la mia gratitudine nei confronti della musica classica. Indubbiamente direi che, ormai da anni, intratteniamo un rapporto di stretta familiarità, anzi più propriamente di autentica confidenza. Nel corso della mia giornata e nello svolgimento della mia attività creativa, mi ritrovo spessissimo da solo in compagnia della musica. E allora mi apro a lei, mi confido appunto, condividendo speranze e delusioni, desideri e paure. Lascio che la musica mi ispiri e, in un certo senso, mi guidi e non è raro, per quanto possa suonare incredibile, che la scelta – inizialmente del tutto capricciosa – del compositore o dell’opera che dovranno accompagnarmi in un dato momento si riveli, col passare del tempo, la più coerente alle emozioni del momento. Ma, forse, è proprio il mio stato emotivo ad adeguarsi progressivamente alle note, a prendere forma attorno a loro.
La musica del resto, almeno per come la immagino io, è precisamente forma e – sebbene, questa forma, io non riesca a riprodurla attraverso alcuno strumento – mi sforzo ogni giorno di ricercarla attraverso le parole. Oltre a un’idea, scrivere richiede una forma, che dovrebbe risultare il più possibile in armonia con l’idea che pretende di esprimere. Nella ricerca dell’armonia la composizione classica, con la capacità di farsi lieve nonostante la sua straordinaria complessità, costituisce un riferimento essenziale.
Il libro è un giallo ed è avvincente e ben orchestrato (non farò spoiler, ovviamente), ma oltre a seguire gli sviluppi del caso, la lettura si snoda su più linee narrative che vanno non solo a toccare, ma anche a sviscerare temi ontologici e sociali complessi. Come se la ricerca di Fabrizio (il pianista del libro) di Mefistofele nella musica che compone si proiettasse in una ricerca più ampia del Male – o meglio, dei mali – nella natura umana. La musica e l’arte in generale rappresentano un punto di partenza privilegiato o svantaggiato per avvicinarsi alla comprensione del mondo?
Ritengo che l’arte sia lo specchio attraverso il quale il mondo, con tutte le sue luci e le sue ombre, può essere osservato, indagato, ripensato. Quello specchio riflette il mondo su due diverse facce: non si tratta soltanto di ricercare una rappresentazione pedissequa e per così dire passiva, bensì di compiere una trasfigurazione che vada oltre la mera apparenza di un oggetto, pur di riuscire a coglierne l’intima natura. È l’obiettivo dell’espressionismo, consistente appunto nel tirare fuori da ogni cosa la sua identità. L’arte e la musica sono precisamente un’indagine e una presa di posizione identitarie. O, perlomeno, io sono convinto che dovrebbero sforzarsi di esserlo.
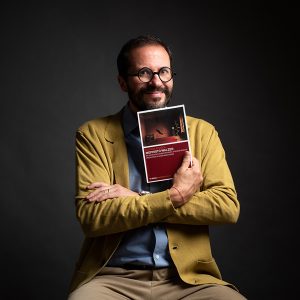 Il fatto è che tutti i personaggi del libro hanno qualcosa da nascondere, incluso Fabrizio, che è molto distante dall’ideale dell’artista tormentato ma dall’animo nobile. Anzi ci appare come un personaggio fragile, manipolabile e non sempre onesto. Perché la musica per lui non è forza e sollievo, ma si lascia costantemente trascinare dalle pulsioni del mondo?
Il fatto è che tutti i personaggi del libro hanno qualcosa da nascondere, incluso Fabrizio, che è molto distante dall’ideale dell’artista tormentato ma dall’animo nobile. Anzi ci appare come un personaggio fragile, manipolabile e non sempre onesto. Perché la musica per lui non è forza e sollievo, ma si lascia costantemente trascinare dalle pulsioni del mondo?
Perché esiste un conflitto tra l’aspirazione a ricercare la virtù e l’armonia, in una parola il bene, e l’irresistibile fascinazione del male. La musica e l’arte dovrebbero elevare lo spirito dalla materialità alla quale lo costringe la carne. Ma questa è costantemente sollecitata e fatalmente attratta dagli stimoli che esercita su di lei la materia. Si può perciò dire che il romanzo sia dedicato al tema della tentazione (della quale Mephisto è maestro) e al tema del conflitto interiore che sovente viene affrontato attraverso l’ipocrisia. Questa non sana affatto il conflitto, ma ha la capacità di celarlo. Sia allo sguardo altrui sia, soprattutto, al proprio.
Fabrizio, come ogni artista, si ritrova in continuazione a sentirsi solo. Eppure non lo è mai: egli è costretto a sopportare costantemente la presenza della propria coscienza. E ciò precisamente in ragione della sua vocazione di artista a guardare il mondo e se stesso attraverso quello specchio duplice e ambivalente, che non si contenta di restituire l’aspetto esteriore, ma svela ogni intimo segreto che, pure, si vorrebbe nascondere e, in definitiva, dimenticare.
A me è sorto spontaneo un paragone tra Fabrizio e il principe Myškin de L’idiota, ma non so se sia pertinente o se sia dovuto al fatto che io sono ossessionata dal testo di Dostoevskij e tendo a vederne riferimenti un po’ ovunque, come la rucola al ristorante. C’è davvero o me lo sono immaginato?
Di certo Dostoevskij, che io considero un maestro dell’espressionismo (come ho cercato di spiegare nello studio dedicato a Sir William Shakespeare, buffone e profeta), è uno dei riferimenti letterari e ideologici di Mephisto Walzer. A cominciare proprio dal tentativo di sintetizzare narrazione e riflessione – o, in altre parole, romanzo e saggio – nella convinzione che il vero oggetto dell’arte debba essere l’uomo e che esso sia contraddistinto da quella già citata complessità che condivide appunto con la composizione classica e che rende quest’ultima uno strumento privilegiato di indagine psicologica.
Personalmente sono portato a ritrovare in Fabrizio e non soltanto in lui più analogie con la doppiezza piccolo-borghese di Goljadkin e Raskol’nikov, incapaci di reggere il confronto con la propria dilacerata coscienza. Tuttavia sono felice che il personaggio si presti a letture differenti sebbene affini, confermando la mia convinzione che a ogni lettore corrisponda, almeno in parte, un differente libro. La circostanza che altri colgano nel mio testo qualcosa che a me è sfuggito dimostra che quel testo ormai ha visto la luce, parla da sé, vive di vita propria. E non credo che un autore possa augurare di meglio alla propria creatura.
Tornando a Dostoevskij (ho già detto che ne sono ossessionata) abbiamo anche Virginia che rappresenta nuovamente una forma di bellezza che non salva il mondo, anzi Virginia vuole oscurare la propria bellezza, sporcarla quasi per sentirsi accolta come essere umano fatto di carne e sangue e non come un’immagine da copertina. La bellezza non salva perché quelli che la possiedono – mi riferisco a Fabrizio e Virginia ma anche alla passione per la fotografia del commissario – non sanno farne buon uso, o perché il grande male che è nel mondo ha comunque la meglio?
Di certo la bellezza è, nell’immaginario tradizionale occidentale, un attributo inseparabile della virtù. Vero è che la virtù costituisce un premio a se stessa, mentre la bellezza esteriore non può essere goduta che da altri. E allora ciascuno ricerca la bellezza altrui: c’è chi si limita a godere della sua contemplazione, chi avverte il bisogno di prendersene cura e chi, infine, pretende invece di possederla in maniera assoluta ed esclusiva. Ecco che la bellezza si trasforma allora in ossessione per chiunque voglia appropriarsene e in pericoloso strumento di scambio o di potere per chi ne abbia ricevuto il dono. È evidente che emerge una visione molto più prosaica che poetica della bellezza. Ma, purtroppo, le relazioni umane sono perlopiù improntate alla prosa della sopraffazione, anche quando questa si ammanta del nome di amore.
Mefistofele, tanto evocato, sicuramente compare più volte nel corso della narrazione. Dopotutto si sa che, se lo si evoca, compare, ma non lo fa annunciandosi in pompa magna, ma strisciante e inatteso, come è appunto nella sua natura ed è proprio nascondendosi nei dettagli che trionfa. Se non ci salva la bellezza, possiamo almeno cercare di smascherarlo e non farci trarre in inganno dalle sue molteplici maschere?
Non so se dal male, almeno in questa esistenza terrena, possa esserci scampo. Il male è connaturato all’uomo e non esiste essere umano dotato di una coscienza pienamente funzionante che possa mantenersene indenne. Temo che la verginità sia attributo soltanto dell’idiozia – per tornare al riferimento dostoevskiano. Un’idiozia che corrisponde alla più perfetta ingenuità. Del resto, l’etimologia del termine ingenuo richiama un’idea di libertà (in questo caso dal male) ormai preclusa al cittadino moderno.
Nella società moderna Mefistofele è ovunque, a cominciare dalla nostra interiorità. E, forse, la sola maniera di riconoscerlo è guardare nello specchio bifronte dell’arte, spingendoci oltre la nostra ipocrita apparenza, prendendo piena coscienza della nostra autentica natura.
Per questo però occorre coraggio. E, naturalmente, occorrono artisti – se coraggiosi, anche meglio!